I consigli “di carta” apparsi nella nostra newsletter TURING vs ASIMOV nella prima metà del 2025: tra fisica, tecnologia, matematica, scienza e fantascienza… e tu, cosa leggerai quest’estate?
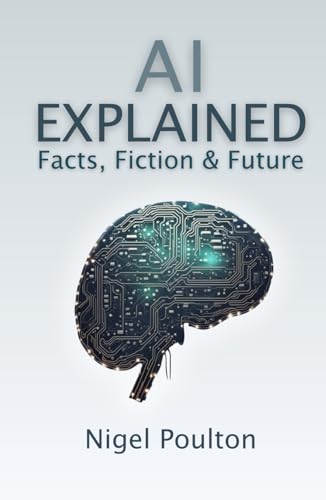
Il contenuto del libro “AI Explained: Facts, Fiction, and Future” di Nigel Poulton è correttamente descritto nel titolo. L’autore parte dall’idea di spiegare i concetti di base dell’AI senza essere didattico.
Niente tecnicismi fuori luogo per avere un’idea generale della moderna AI e molti risultati di “esperimenti” con vari modelli in voga oggi.
Testo che probabilmente invecchierà velocemente ma gradevole oggi. Utile per chi conosce poco il tema e interessante per chi lo conosce già.
I limiti della razionalità. Intuizione, logica e trance-logica di László Mérö cerca di indagare il rapporto tra logica e psiche.
Mérö è un matematico psicologo (a molti può sembrare un ossimoro) e il suo libro è un buon compromesso tra il formale e l’intuitivo.
Pubblicato una ventina di anni fa, il libro sembra essere più rilevante oggi poiché considerazioni relative al comportamento umano, e a quella che nel libro viene chiamata la trans-logica, iniziano ad essere applicabili all’AI in genere e ai LLM più nello specifico.
Buona lettura per chi ha una mente aperta (come gli iscritti alla nostra newsletter!).


Se la vita non è un sogno potrebbe essere un gioco. Nel caso, sia per i lettori più tecnici, sia per chi non tecnico è curioso di come funzionano le cose in un videogioco, può essere interessante leggere “Game programming patterns” di Robert Nystrom.
Il libro è un manuale che ha il pregio raro (per i manuali) di cercare una visione d’insieme.
Per chi è più tecnico, il libro presenta anche esempi di codice in C++.
Il libro Tik Tok di John Sladek, scritto nel 1983, in superficie racconta la storia di un robot domestico psicopatico. Il tema sembra poco originale, ma il racconto lo presenta dal punto di vista del robot e della sua necessità psicologica di compiere atti contro gli esseri umani.
Azioni come assassinio e pittura sono presentati affiancati e, almeno in parte, mostrano la ricerca di indipendenza per affrancarsi dal ruolo di schiavitù dei robot servitori.
Interessante e strano racconto con diverse chiavi di interpretazione. Oggi sicuramente più verosimile di quando è stato scritto.
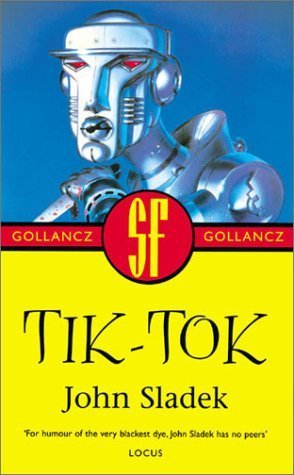
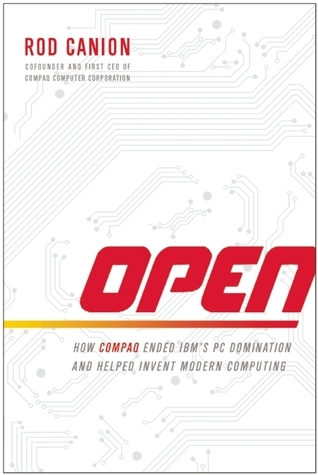
Si dice che la storia tende a ripetersi. Frase apodittica e semplicistica. Si può comunque partire da questa ipotesi nello studio della storia di come Compaq ha battuto IBM alla fine del secolo, per provare a leggere cosa succede tra i colossi AI di oggi (vedi, mutatis mutandis, Deepseek).
Un libro (di parte) che racconta questa storia è “Open: How Compaq Ended IBM’s PC Domination and Helped Invent Modern Computing” di Rod Canion (cofondatore di Compaq). Storia scritta in modo diretto e interessante. Utile come monito per quelli di voi che gestiscono aziende grosse come IBM.
A noi ignoranti molte idee sembrano uscire dalla mente geniale di un singolo in un magico momento di illuminazione. Leggendo il racconto breve “Una relazione per un’Accademia” di Franz Kafka, del 1906, si trovano diversi ponti a isole successive. La storia è quella di una ex scimmia che, umanizzata, racconta all’accademia la sua storia. Interessante per molti punti di vista.
Precursore, ad esempio, de “La planète des singes”, il “Il pianeta delle scimmie” di Pierre Boulle, scritto nel 1963 e forse più carico di contenuti.
Consigliato alle scimmie come noi che sono costrette ad atteggiarsi a umani.
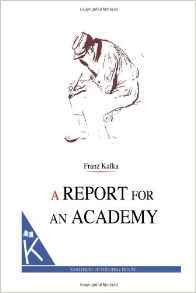
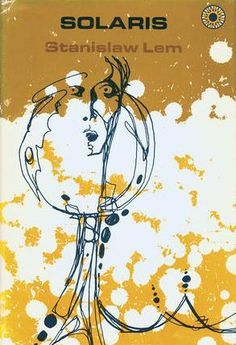
Solaris di Stanislaw Lem è, a ragione, un libro di culto. L’idea su cui fa perno la storia è molto interessante; senza troppi spoiler, il punto di vista è quello del contatto con un’entità aliena, interpretato agli antipodi di una storia di alieni standard. Qui l’entità è fisicamente e “mentalmente” incomparabile con quella umana. L’alieno, enorme quasi quanto la superficie di un pianeta, esiste letteralmente su un altro piano.
Mutatis mutandis, si potrebbe affiancarlo a quello che potrebbe diventare tra un po’ di anni una super AI (ammesso che la non legge di Moore dell’AI mantenga la sua validità).
Come le altre opere di Lem, il libro non si limita alla sua idea fantascientifica ma, in questo caso, la usa per esplorare la mente umana in un allucinatorio rapporto tra l’entità e gli esploratori mandati sul pianeta per studiarla.
Libro bello e classico, con un involontario tocco retrofuturistico. Da leggere possibilmente prima di vedere la sua classica trasposizione cinematografica di Tarkovsky del 1972.
Questo consiglio di carta non è un libro, ma un breve saggio disponibile online: “Notation as a Tool of Thought”, scritto da Kenneth E. Iverson (importante informatico, creatore del linguaggio APL e Turing Award nel 1979).
È una piccola gemma datata 1979 che, presentando la notazione del linguaggio di programmazione chiamato APL (un linguaggio di nicchia ormai stagionato, ma che mantiene intatta la sua caratteristica rivoluzionaria rispetto allo status quo), riflette sull’importanza della rappresentazione dei concetti come strumento del pensiero prima che dell’implementazione. Profondo e gradevole, il saggio risulta utile non solo ai tecnici, ma anche (forse soprattutto) alle menti curiose in genere.

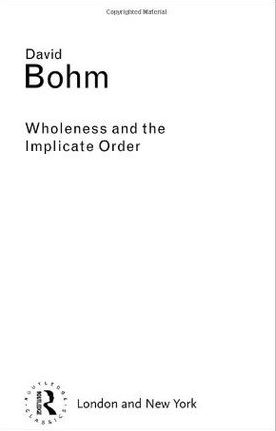
“Wholeness and the Implicate Order” è uno degli scritti nel quale David Bohm, uno dei fisici più importanti del secolo scorso, cerca di rappresentare la sua teoria di una realtà antimeccanicistica e antiriduzionista.
Le teorie presentate da Bohm cercano un collegamento tra realtà fisica, realtà mentale e metafisica.
Presentato in questo modo il libro può sembrare complesso, ma in realtà è relativamente abbordabile. Bohm è capace di presentare in modo semplice concetti filosofici senza sminuirli. Parte più ostica (ma limitata a poche pagine) probabilmente è quella dove entra nei dettagli della meccanica quantistica.
Sicuramente merita una ri-lettura anche (ma non solo) perché è compatibile con un’interpretazione potenzialmente non-ortodossa dell’AI.
“Pensieri della mosca con la testa storta”, di Giorgio Vallortigara, è un libro che può interessare a molti, per ragioni molto diverse.
È una bella riflessione su mente, cervello e coscienza. Il saggio è ben piantato su un punto di riferimento – quello dello studio di esseri viventi con cervelli minuscoli – che lo rende molto concreto.
Pregio raro, il saggio è apertamente critico rispetto al fumoso utilizzo della teoria della complessità per giustificare l’emergere della coscienza.
Dal punto di vista contrario, l’approccio è quindi riduzionista e potrebbe lasciare parzialmente insoddisfatti i palati più schizzinosi.
Saggio rapido e interessante, scritto da una persona colta che scrive in modo non ampolloso.
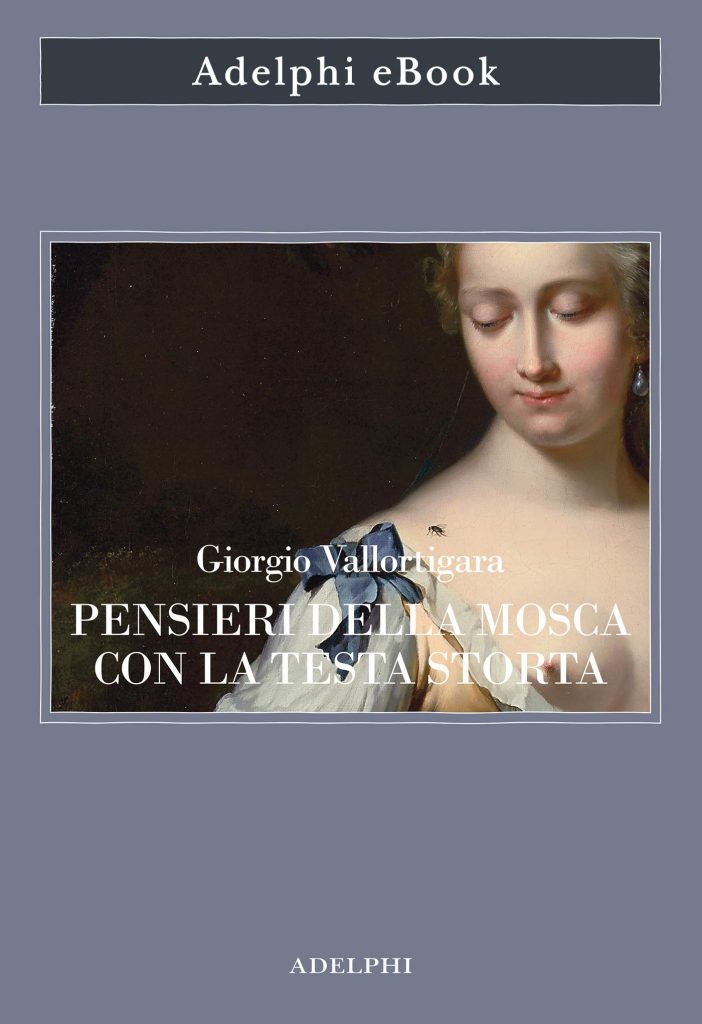
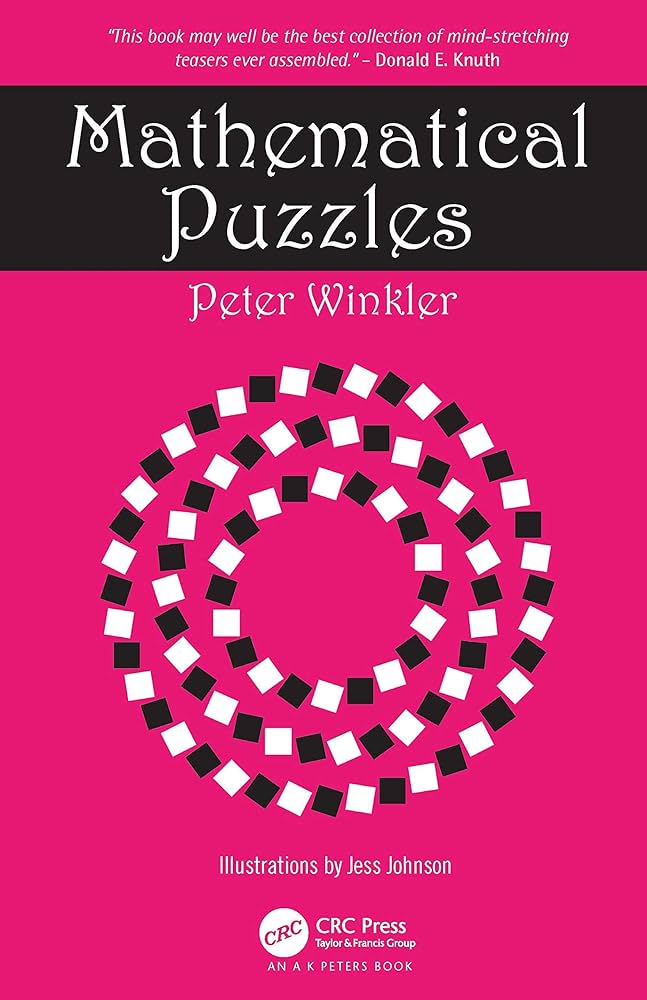
Qualcuno dei nostri lettori potrebbe avere la rara fortuna di avere tempo e tranquillità da consumare nella prossima estate.
Il consiglio di carta questa settimana è una lettura particolarmente adatta allo scenario idilliaco menzionato. Mathematical Puzzles di Peter Winkler è una collezione di puzzle matematici non banali, che necessitano tempo e testa per essere risolti. Non è un’accozzaglia di rompicapi, ma un percorso ben costruito per chi apprezza la matematica, gli algoritmi e le sfide.
Ci sono molti capitoli gradevoli (il libro è lungo più di 400 pagine e può essere affrontato in modo non lineare), come ad esempio quello che tratta il rapporto tra i nimeri e i codici di Hamming.
I quesiti sono accompagnati da soluzioni ben argomentate quindi, per chi ha più fretta, anche una lettura veloce può risultare un interessante percorso matematico.
Nel 2025, l’uomo è antiquato? Secondo lo storico saggio del filosofo Günther Anders, l’uomo era già antiquato nel 1956. “L’uomo è antiquato. Vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale” è calato nelle rivoluzioni del tempo ma è riproponibile in modo inquietante nella realtà attuale.
La prima parte discute di quella che è definita la “vergogna prometeica”, legata al fatto che l’uomo non è così perfetto rispetto alle macchine che costruisce.
Continua poi nell’esplorare i concetti di “fantasma” e “matrice”, connessi alla riproduzione e al modello, che sostituiscono l’originale (l’uomo) nel concetto di verità. Qui è necessaria solo una semplice traslazione da radio e tv ai media odierni.
Viene poi utilizzata la metafora di “Aspettando Godot” per descrivere la condizione umana in una realtà naturalizzata, tecnocratica e secolarizzata.
La parte finale del saggio, invece, analizza l’impatto filosofico dell’introduzione della bomba atomica come concetto nichilista e fuori dalla storia (perché ha la potenzialità di terminare la storia). La bomba è presentata come “reductio ad nihil”, come contrasto alla “creatio ex nihilo”. Oggi però l’equivalente tecnologico della creatio ex nihilo è (forse) alle porte e altrettanto apocalittico.
Ottimo dal rileggere o leggere per venire a contatto con idee che fanno apparire le moderne elucubrazioni filosofiche sulla modernità delle chiacchiere di poco spessore.

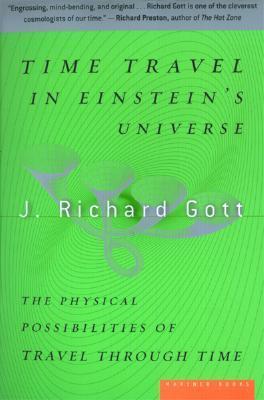
“Time Travel in Einstein’s Universe: The Physical Possibilities of Travel Through Time”, scritto da John Richard Gott III, è un buon libro leggero impegnato, utile se si sente la necessità di portarsi a pari (almeno dal punto di vista divulgativo) con le teorie che riguardano i viaggi nel tempo.
La scrittura è molto scorrevole e le idee sono molto interessanti. John Richard Gott III è un importante professore di astrofisica a Princeton con un ego abbastanza pronunciato. Questo traspare nella sua scrittura, ma il libro non ne risente troppo. Alcuni ragionamenti, pur avendo un fondamento matematico solido, sono un po’ deboli dal punto di vista filosofico. Libro “divertente” che permette di essere letto a più livelli, sicuramente accessibile a tutti i lettori curiosi.
“Modal Logic for Open Minds” di Johan van Benthem è un libro che affronta in modo comprensibile un tema complesso.
La logica modale è uno strumento utile nell’articolazione del pensiero logico, ma soffre di una letteratura che la rende ostica per i non addetti ai lavori. La sua utilità potenziale è molto vasta perché permette di comprendere meglio concetti chiave in molti settori, a partire dai linguaggi di programmazione, passando per la teoria dei giochi per arrivare all’AI. Il tema può essere interpretato da diversi punti di vista, ma in generale è l’estensione di modelli di logica classica a diversi mondi potenziali. Ad esempio, coglie il fatto che alcune cose sono vere ad un certo punto di un programma o di un gioco, ma non lo sono più in fasi successive.
Il libro è quindi molto consigliato per chi ha la passione necessaria per intraprendere questa strada.
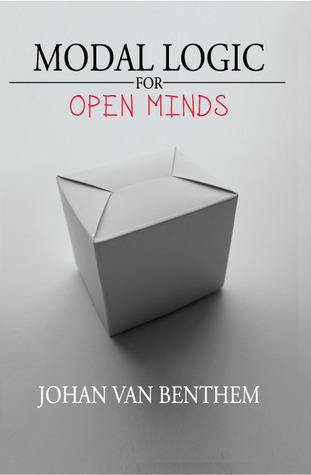
Sei in cerca di ulteriori titoli? Fruga tra i nostri post nella categoria Books.
Vuoi consigliarci un libro o conoscerci meglio?
Scopri di più su www.eliflab.com o contattaci info@eliflab.com